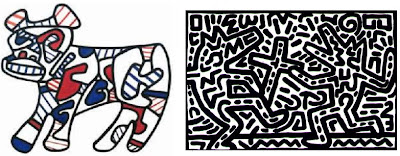NANNI MORETTI - 1989
 |
Gli spazi chiusi in questo caso sono l’Io del protagonista e il quadrato circoscritto della piscina con i relativi spalti. Chiusa a cerchio entro due incidenti anche la durata filmica il cui svolgimento non è però lineare ma va a costruire un tempo che dall’infanzia di Apicella/Moretti giunge al presente e trova quasi perfetta sovrapposizione con il tempo dilatato della partita di pallanuoto, vero palinsesto su cui si innestano altri testi o spunti narrativi.
E gli spunti narrativi, proposti con il solito irritante modo apodittico e sentenzioso, sono davvero molti e presi singolarmente hanno spesso anche indiscusso valore e originalità ma che nel loro insieme non riescono a tradursi in un’ opera organica, coerente, leggera, usando quest’ultimo termine nell’accezione usata da Calvino nelle Lezioni americane. Infatti Palombella rossa è soprattutto un film pesante, pesantissimo che nonostante gli sketch divertenti va a fondo come piombo nella piscina di Acireale.
Messo subito in chiaro il principale difetto del film, esso presenta comunque molti pregi, che ne fanno, come si diceva all’inizio, uno dei film più importanti della cinematografia italiana degli ultimi decenni.
Innanzi tutto, aspetto principale del film è il tentativo di fare una riflessione sul linguaggio. Palombella rossa, oltre che ad essere la solita testimonianza di narcisismo egocentrico da parte di Moretti, è un film sul linguaggio ma le conclusioni restano superficiali, da comicità televisiva, capaci solo di proporre qualche affermazione banalmente saggia: Chi parla male, pensa male e vive male; Le parole sono importanti; La vita di un uomo viene sporcata per sempre se qualcuno ne parla su un settimanale; Guarda, non bisogna leggere, ma non bisogna nemmeno scrivere perché un concetto, appena viene scritto, ecco subito che diventa menzogna.
Va comunque detto che l’accostamento di codici linguistici diversi è una bella trovata. Come la ripresa televisiva e gli stilemi del giornalismo, il super 8 amatoriale e la superproduzione cinematografica, i tecnicismi sportivi e il politichese.
Vi sono poi le considerazioni sul comunismo, diventate, in Italia, la cifra che ha segnato il dibattito sul film e che tracciano l’aspetto più legato alla situazione nazionale, limite che però ha dato voce ai turbamenti della sinistra specie nell’anno che si era aperto con la repressione di Piazza Tienanmen e le proteste di Vilnius, ma di questo nel film non c’è traccia e la crisi di identità della sinistra si riduce a dibattito da festa dell’Unità di provincia. Moretti riduce tutto in macchietta, con il solito uso di quelle espressioni codificate contro le quali Michele si scaglia (Noi siamo una forza come le altre: siamo uguali, anche se siamo diversi)
Altro tema è quello della memoria. Memoria individuale e collettiva, perduta e ritrovata, con l’urlo liberatorio dell’invocazione disperata al tempo perduto: le merendine, i pomeriggi di maggio, il brodo di pollo!. E proprio questo assieme all’incitamento di fronte al finale di Zivago e alla tribuna elettorale che diventa E ti vengo a cercare restano i momenti migliori del film.
Ma Palombella rossa è molto altro ancora. È un film cattivo e violento, in cui tutti parlano e vomitano le proprie verità e nessuno ascolta, che evidenzia la contrapposizione tra individuo e gruppo.
È infine un film che annovera elementi fortemente nazional-popolari: padri, madri, figli, lo sport, lo spirito di squadra, i cori, il PCI e la Chiesa, il tema di Lara e Piovani…
Sì, c’è troppo, troppe parole, troppo Moretti.